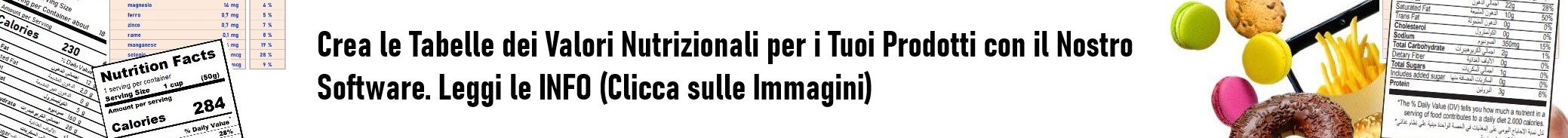Calcolo dei Valori Nutrizionali con Programma in Formato Excel
Abbiamo messo a punto un programma per il calcolo dei valori nutrizionali in formato excel affidabile e semplice da utilizzare. Leggi le info
Programma in formato Excel per Gestire Rintracciabilità, Costi di Produzione e Giacenze di Magazzino
Programma in formato excel versatile, semplice ed intuitivo per gestire i costi, la rintracciabilità e le giacenze
Come Creare le Etichette per Esportare i Prodotti Alimentari in America
Vuoi esportare i tuoi prodotti alimentari in America? Vi spieghiamo come approntare l’ etichetta nutrizionale.
Nuove regole UE sull’etichettatura dei vini in ottemperanza al regolamento UE 2021/2117: guida della commissione europea
Nuove regole UE sull’etichettatura dei vini: la chiarezza al servizio del consumatore